Come gli angeli giungono a noi
 HELMUT FISCHER,
HELMUT FISCHER,
Claudiana Editrice, Torino, 2015,
pp. 107, Euro 14,90
Breve e semplice questo testo di Helmut Fischer, teologo tedesco, che, con un linguaggio colloquiale e scorrevole, affronta un tema teologico denso e ricco di spunti e riferimenti interculturali, senza appesantirlo con disquisizioni dogmatiche o filosofiche, ma limitandosi a tracciare una sintesi, comunque completa per quanto ci interessa, della storia dell’angelologia. Il testo perde, ovviamente, di profondità accademica, ma ci guadagna in chiarezza e semplicità. E’ quindi un libro divulgativo, alla portata di tutti, che parte dalla constatazione di come, nonostante la secolarizzazione, la laicizzazione e la modernizzazione della nostra società e delle religioni, l’interesse per gli angeli non solo non sia diminuito, ma anzi accresciuto, e come la fede negli angeli sia presente anche in coloro che non professano una fede religiosa. Il libro contiene innanzi tutto una storia dell’origine della figura angelica, che non è specifica del cristianesimo, ma ha i suoi precursori in altre culture, in particolare nell’ebraismo, nello zoroastrismo e nell’ellenismo, cui si aggiungono nel tempo le influenze di sistemi filosofici, come lo gnosticismo e il neoplatonismo. Gli angeli nascono dall’esigenza di avere un intermediario, man mano che si affermano la trascendenza di Dio e il monoteismo: essi assumono i ruoli prima svolti direttamente da Dio nel suo rapporto con gli uomini e nel cristianesimo primitivo ereditano le funzioni già ricoperte nell’Antico Testamento: sono interpreti, messaggeri, aiutanti. Con il tempo il sistema angelico si articola e arricchisce, fino a dare vita alla gerarchia dello Pseudo Dionigi, che li suddivide in tre triadi, ognuna delle quali viene analizzata da Fischer, con riferimento anche alla sua rappresentazione figurativa: dall’aspetto di uomini barbuti o di giovani imberbi all’acquisizione dell’aureola e delle ali, dai simboli della sfera, dello scettro, degli abiti, del diadema, agli attributi del giudizio apocalittico, come la tromba o la spada. L’autore affronta poi la storia degli angeli nel Medioevo latino, nella Scolastica, nella Riforma, nell’Illuminismo, nel mondo cattolico ed ortodosso, cercando di evidenziare la concezione che di volta in volta è prevalsa: accettazione o rifiuto, interpretazione salvifica o simbolica, rifiuto del culto o uso nella liturgia. Una particolare attenzione è dedicata alla figura dell’angelo custode, che ancora oggi conosce un grande sviluppo nelle scienze e nelle arti. Col tempo gli angeli si modificano, acquistando maggiore realismo e perdendo il proprio significato religioso, fino a diventare gli amorini, simboli terreni del piacere sensuale. Il testo, arricchito da molte illustrazioni, termina con alcune riflessioni sul significato dell’angelo oggi, nella nostra vita personale: può essere considerato il messaggio d’aiuto nel bisogno o il messaggero che ci dà la forza di accettare ciò che non possiamo cambiare: è comunque un segno della presenza di Dio nella nostra vita.
Antonella Varcasia










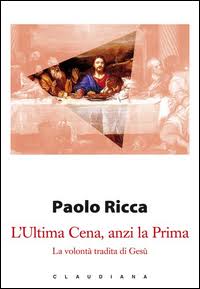

 FRANKE John R.,
FRANKE John R.,

